Diario del 27° corso di alpinismo del CAI Piacenza
testo di Gabriele Villa
foto di Michele Bacci, Matteo Malchiodi, Luciano Masera, Gabriele Villa
Piccola premessa di carattere
strettamente personale
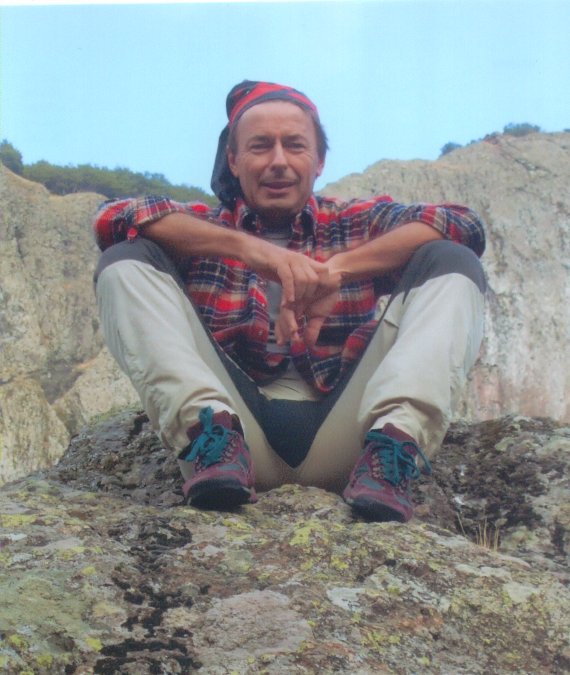 Ricordo, oramai qualche anno fa, nel pieno di un’infervorata discussione
sull’arrampicata, sulla didattica e gli scopi dei corsi di roccia e
alpinismo, sulle dinamiche interpersonali all’interno della vita
associativa del Cai, sentirmi rivolgere una domanda netta, a bruciapelo,
con decisione quasi provocatoria: “Ma tu, non ti sei ancora stancato
di fare il Don Chisciotte?”
Ricordo, oramai qualche anno fa, nel pieno di un’infervorata discussione
sull’arrampicata, sulla didattica e gli scopi dei corsi di roccia e
alpinismo, sulle dinamiche interpersonali all’interno della vita
associativa del Cai, sentirmi rivolgere una domanda netta, a bruciapelo,
con decisione quasi provocatoria: “Ma tu, non ti sei ancora stancato
di fare il Don Chisciotte?”
A rivolgermela un’amica arrampicatrice, nota per il suo carattere deciso
e un po’ teutonico; ma già altri amici me l’avevano accennata anche se
in termini più sfumati e pure io, in fondo, me l’ero posta, dubbioso:
“Ma ne vale ancora la pena?”
E sempre a rispondermi che sì, bisognava continuare a difendere idee e
metodi in cui si crede, se si ritiene che possa essere utile
all’associazione o anche a qualcuno all’interno di essa (allievi dei corsi o anche solo singoli soci).
Insomma Don Chisciotte non si stancava di combattere i mulini a vento
perché sentiva di avere dietro a sé qualcuno da rappresentare, fosse
anche solamente il fido Sancho Panza a dare senso a quell'impari lotta
che di senso sembrava sempre più perderne.
Poi un giorno qualcosa era successo, qualcosa di grave, di sgradevole,
talmente insopportabile che pure Sancho Panza se n’era andato,
silenzioso, rassegnato e deluso, facendo perdere a Don Chisciotte anche
l’ultima ragione del suo utopistico combattere.
Bisognava a quel punto deporre la lancia, gettare l’oramai inutile
scudo, togliere elmo e corazza, fermarsi a pensare, forse anche a
soffrire, e magari mettersi a cercare un territorio nuovo dove non ci
fossero lotte inutili a sfiancare la psiche, a bruciare energie nervose,
a sottrarre tempo ad iniziative utili e gratificanti, ma piuttosto
occasioni per rigenerare entusiasmi, o quantomeno non bruciarne il
rimanente e, infine, ritrovare la voglia di spendersi.
Con questo spirito mi sono avvicinato al 27° Corso di Alpinismo del CAI
di Piacenza, ex Don Quixote divenuto caballero migrante, non più alla
ricerca di mulini a vento, ma di me stesso, di nuove amicizie ed
esperienze rigeneranti, oltre che di ridare un senso compiuto al mio
essere Istruttore di Alpinismo.
Piacenza, martedì 6 marzo 2007
Con lo stesso spirito avevo presentato, pochi mesi prima, la domanda di
ammissione nell’organico della Scuola di alpinismo “Bruno Dodi” di
Piacenza ed ero felice di essere stato accettato.
Avevo in seguito dato la mia disponibilità per il 27° corso di alpinismo
che significava, in soldoni, partecipazione a tutte le uscite (7 per un
totale di 10 giorni di esercitazione) e ad alcune lezioni teoriche da
concordare con il direttore (un totale di 20 serate, mica scherzi).
Ed il 6 marzo il muso della mia Punto mirava dritto in direzione
Piacenza per l’inaugurazione del corso e la prima teorica, sul cruscotto
una cartina con la piantina della città ed il tracciato per arrivare al
parcheggio e alla vicina sede del Cai.
Mentre salivo, più tardi, le scale dell’antico “maniero” in cui è
ospitata la sede mi chiedevo perché quasi tutte le sedi delle sezioni
Cai siano così “uguali”, con quell’odore caratteristico di “antico” e
tutte quelle cose tipiche di ogni sede (le foto storiche, gli armadietti
dei materiali, le bacheche cariche di avvisi e comunicazioni ai soci, i
gagliardetti, ecc. ecc.). Infine ecco il salone, le seggiole in file
ordinate, il “trampolone” multi usi (porta proiettore, aggancio per
cordini e moschettoni, scala), la vecchia lavagna a quadretti con il
gesso e la cimosa, la cattedra, un tavolone con relative seggiole. Ma
non è l’abito che fa il monaco, si dice, e non è la sede che fa il
corso, bensì la gente che insegna e quella che “è insegnata”. E arrivano
alla spicciolata gli allievi, vanno al tavolo del direttore, chi sbriga
formalità, chi versa un acconto, chi consegna un certificato medico.
Quello che colpisce è la miscellanea di dialetti e di cadenze: si va dal
milanese, al parmense, al toscano, all’emiliano in genere, con tutte le
varie sfumature e io stesso, del resto, ne aggiungo uno.
C’è effettivamente un po’ di tutto, anche come età rappresentate, con
una buona prevalenza di giovani, sia ragazzi che ragazze. Seguono le
presentazioni degli istruttori (un’abitudine, segno di buona educazione,
che non tutti rispettano…) e poi si comincia la didattica. L’avventura è
iniziata e, tutto sommato, il primo impatto è più che buono.
Val d'Aosta, domenica 18 marzo 2007
 Il trasferimento da Piacenza verso la Val d’Aosta avviene con il pullman,
destinazione Gressoney.
Il trasferimento da Piacenza verso la Val d’Aosta avviene con il pullman,
destinazione Gressoney.
Chi mai l’avrebbe detto di finire fino in Val d’Aosta per la prima
esercitazione con piccozza e ramponi?
Capisco di essere entrato in un’avventura fuori dei confini geografici
che mi erano abituali.
In settimana ha nevicato e la bidonvia ci scarica su di una conca in cui
confluiscono le varie piste da sci del comprensorio; ne saliamo una sul
margine in ordinata fila indiana e raggiungiamo, sfondando fino al
ginocchio nella neve fresca, il “terreno” di esercitazione.
Non sarà possibile esercitarsi con i ramponi, ma si lavorerà su tecniche
individuali (i cosiddetti “passi”e il “modulo a croce”), sicurezza con
la piccozza, prove di autoarresto.
La giornata risulta ugualmente proficua e l’ambiente, tipico di alta
montagna, assai stimolante. Al ritorno al parcheggio faccio conoscenza
con quella che scoprirò essere un’abitudine del corso.
Dal bagagliaio del pullman spunta un tavolone di legno, una specie di
“transformer” che prende prima forma e poi posto sul piazzale, mentre da
un po’ dappertutto, spuntano bottiglie di vino (tante) e d’acqua
(poche), qualche birra, salami e formaggi, ciccioli, pane, grissini,
torte di ogni tipo (sia salate che dolci), patatine fritte croccanti e
tutto quanto altro serve a creare gruppo ed a fare allegria. Rimane una
gran quantità di roba ed allora viene nominato sul campo un “cambusiere”
con il compito di conservare le cibarie per la prossima uscita.
Poi il pullman ritorna verso Piacenza e l’allegria del gruppo è
palpabile: c’è chi canta le canzoni anni sessanta (e quali sennò), il
direttore (chi l’avrebbe detto, così burbero all’apparenza) che suona
l’armonica a bocca, chi dorme (il sottoscritto) cullato da
quest’atmosfera piacevole che lo riporta ad esperienze pregresse,
altrettanto belle (anche se un po’ datate), e mai dimenticate.
Rocca del Prete, domenica 25 marzo 2007
Quando parte la fila di auto da Piacenza piove e, dicono le notizie,
nevica sull’Appennino.
Avrebbe dovuto essere Val d’Aosta, poi commutata in Monte Penna, infine,
mancando le condizioni, in Rocca del Prete. “Quando ci sono brutte
condizioni atmosferiche il posto più sicuro è quello che conosci
meglio”, all’insegna di questa saggia massima ci si prepara e si sale
fino all’imbocco del canale Martincano, una delle vie d’accesso alla
sommità della Rocca del Prete. Qui si formano le cordate (due allievi e
un istruttore) e s’inizia a salire il canale di roccette sommerse di
neve, oramai ce n’è un mezzo metro.
Ramponi ai piedi e piccozza alla mano si sale in cordata applicando i
metodi di assicurazione imparati nell’uscita precedente, mentre, fitta e
silenziosa, la neve continua a cadere sul gruppo che, ben attrezzato ed
equipaggiato, non batte ciglio. Quando il canale si fa più ripido,
s’imbocca un’ampia cengia verso destra e poi un ripido pendio di
roccette ed erba dove, prudenzialmente, ogni istruttore prende il
comando della rispettiva cordata.


Una fascia di roccette viene superata con l’utilizzo di una corda fissa
e infine un ripido canale erboso e con alberi consente di uscire sulla
cima pianeggiante. Intanto oramai è bufera di vento e neve ed i primi
usciti sulla cima aspettano ben due ore l’arrivo dell’ultima cordata
impegnata nella salita, poi, il gruppo compatto, compiendo un ampio giro
rientra alle auto per la strada più sicura, trovando infine rifugio in
un ristorante non troppo lontano, dove salami, ciccioli, formaggi,
dolci, vino e il caldo di un fuoco nel camino ritemprano dai disagi e
dalle fatiche della fredda giornata.
Palestra del Budellone, domenica 15 aprile 2007
 Un inconsueto appuntamento mi attende, alle ore otto, all’uscita
autostradale di Brescia Est.
Un inconsueto appuntamento mi attende, alle ore otto, all’uscita
autostradale di Brescia Est.
La giornata è buona, il sole primaverile si fa ben sentire e la
temperatura è decisamente sopra la media stagionale.
La mèta della giornata è la palestra denominata “Budellone”: mi
aspettavo una gola ombrosa e umida ed invece è un posto solare, con un
calcare magnifico e ben lavorato, esposto in pieno sud a quota
decisamente bassa, il che vuol dire, caldo e tanta vegetazione…
parietaria (molto abbondante) compresa.
Per chi non lo sapesse la parietaria è una pianta che cresce sopra i
muri e sulle rocce a bassa quota, quindi praticamente ovunque. Chi
invece ne è allergico, come me, sa bene che intendo dire.
Sono iniziali starnuti in serie, pruriti agli occhi e al naso, poi… si
fa didattica.
Oggi si imparerà a preparare i punti di rinvio con ancoraggi naturali,
con chiodi, con dadi contrapposti, con friends, poi si passerà alla
realizzazione di un punto di sosta con collegamento di due chiodi e
gestione del mezzo barcaiolo, infine si proveranno le tecniche
individuali di arrampicata, per concludere con la corda doppia.
Insomma una giornata piena e, quando arriviamo al parcheggio, ed al
tavolo “transformer” imbandito, si mangia con voracità e ci si scambiano
le impressioni sulla giornata.
Il morale della truppa pare veramente ottimo e si può constatare la
generale soddisfazione per il buon andamento del corso. Più tardi
un'ordinata fila di auto si avvia verso il casello autostradale di
Brescia Est e qui, una volta entrata, imbocca la direzione Piacenza,
mentre la mia auto “vira” verso Verona.
Castello di Gaino, domenica 6 maggio 2007
L’appuntamento è ancora al casello di Brescia Est e la meta è il
Castello di Gaino, nelle vicinanze del Lago di Garda.
La giornata è ideale, il sole brilla in un cielo azzurro, ma non fa
caldo e la temperatura è molto gradevole.
Siamo i primi ad arrivare sotto la parete e subito fervono i preparativi
delle cordate per la scalata.
Il programma della giornata è la salita della prima parte di questa
bella cresta di calcare, (che non presentando troppe difficoltà è ideale
per l’approccio all’arrampicata), che gli allievi affronteranno in
cordata guidata prima dagli istruttori sui primi due tiri e poi
“tirando” loro stessi in modo da imparare a proteggersi ed a memorizzare
bene tutte le manovre di sicurezza.
I miei due allievi sono entrambi assenti per cui vengo aggregato ad
un’altra cordata ed arrampico da secondo. Arriviamo sulla spalla di
cresta per primi ed è bello rimanere al sole in attesa degli altri,
godendo di quel panorama affascinante sul Lago di Garda.
Tutto fila liscio ed a metà pomeriggio tutto il gruppo si trova attorno
al solito tavolo “transformer” per concludere la giornata di
esercitazione con il solito spuntino dove ci si scambiano le impressioni
dell’arrampicata.


Dente delle Ali, sabato 26 maggio 2007
 Ed ecco arrivare il primo dei tre fine settimana che completeranno il
corso.
Il teatro delle esercitazioni del sabato è il Dente delle Ali quello
che, nella guida “AEMILIA” che descrive le “arrampicate su roccia e
ghiaccio in provincia di Piacenza”, viene presentato come “la palestra
storica della nostra provincia, la madre di tutte le nostre falesie”.
Ed ecco arrivare il primo dei tre fine settimana che completeranno il
corso.
Il teatro delle esercitazioni del sabato è il Dente delle Ali quello
che, nella guida “AEMILIA” che descrive le “arrampicate su roccia e
ghiaccio in provincia di Piacenza”, viene presentato come “la palestra
storica della nostra provincia, la madre di tutte le nostre falesie”.
Appare subito evidente il grande affiatamento e l’organizzazione del
gruppo istruttori: vengono organizzati due gruppi, uno andrà subito alla
ferrata, l’altro comincerà a provare le manovre di recupero ed emergenza
in cordata su di un sassone alto pochi metri ma perfettamente attrezzato
ed idoneo alla bisogna.
Nonostante le previsioni non tanto buone, la giornata fila via liscia e
soltanto una nuvoletta di passaggio regalerà una quindicina di minuti di
pioggia. Sono nel gruppo che comincia con le manovre, tra carrucole
doppie, spezzoni ausiliari, dispositivi di alleggerimento, asole di
bloccaggio: non tutto è chiaro nella testa degli allievi, ma la materia
è complessa, le cose da sapere sono tante e la manualità ancora in parte
da acquisire.
Poi i gruppi si scambiano le posizioni e così si raggiunge il bivacco
Sacchi, ci si prepara legandosi il dissipatore e lasciando gli zaini
all’interno ed infine raggiungendo l’attacco della ferrata Mazzocchi,
non troppo difficile e inaspettatamente “carina” per la varietà dei
passaggi e delle situazioni; il paesaggio appenninico circostante rende
il tutto suggestivo e inusuale per chi abitualmente in ferrata va solo
in ambiente dolomitico.
Infine i due gruppi si riuniscono e ci si trasferisce sopra ad un salto
di roccia che consentirà a tutti di provare l’ebbrezza di una calata di
30 metri, parzialmente nel vuoto.
La serata si conclude con una cena tutti insieme nell’alberghetto che
già aveva accolto il gruppo dopo “l’invernale” della seconda uscita alla
Rocca del Prete e che ci ospiterà per la notte.
Rocca del Prete, domenica 27 maggio 2007
 L’intero gruppo raggiunge un sassone alto una decina di metri nei pressi
della parete della Rocca del Prete, presso cui saranno effettuate tutte
le prove tecniche sui materiali e le “trattenute” di un volo in parete
ed ancora più evidente appare l’organizzazione meticolosa impressa dal
direttore del corso, Lucio Calderone, ben coadiuvato dai solerti
istruttori.
L’intero gruppo raggiunge un sassone alto una decina di metri nei pressi
della parete della Rocca del Prete, presso cui saranno effettuate tutte
le prove tecniche sui materiali e le “trattenute” di un volo in parete
ed ancora più evidente appare l’organizzazione meticolosa impressa dal
direttore del corso, Lucio Calderone, ben coadiuvato dai solerti
istruttori.
La “sequenza” delle prove è un piccolo compendio di tutto quanto è stato
spiegato nelle lezioni teoriche e che la prova pratica e la
visualizzazione dovrebbero imprimere chiaramente nella memoria di tutti
gli allievi: caduta in ferrata con cordino da 7mm di diametro (che
ovviamente si spezza), cadute con fattore 2 (cinque volte di seguito)
sia con una corda nuova che con una corda parzialmente usurata (che dà
inaspettatamente ottimi risultati, quasi al pari della nuova), caduta
con moschettone a braccetto aperto (che praticamente “esplode” in vari
pezzi) e infine la trattenuta vera e propria da parte di ciascun allievo,
esperienza che mette in evidenza la buona manualità acquisita da tutti.
 Soddisfatti ci si trasferisce sulla parete della Rocca del Prete dove un
tratto ferrato (da fare con dissipatore) conduce su di un pulpito da cui
tutti scenderanno con due corde doppie da fare in sequenza.
Soddisfatti ci si trasferisce sulla parete della Rocca del Prete dove un
tratto ferrato (da fare con dissipatore) conduce su di un pulpito da cui
tutti scenderanno con due corde doppie da fare in sequenza.
Gli istruttori si dispongono nei punti chiave da cui potranno osservare
che tutto venga eseguito senza commettere errori, mentre gli allievi
dovranno dimostrare di avere acquisito la padronanza sufficiente a
garantire loro la sicurezza per poter proseguire autonomamente la loro
attività in montagna.
E’ anche un “esame”, oltre che un’esercitazione didattica, e i
risultati sono soddisfacenti e la cosa è visibile nelle espressioni sia
degli istruttori che degli allievi.
L’ovvia conclusione, al parcheggio, attorno all’immancabile
tavolo “transformer”, sancisce l’ottima riuscita di questo fine
settimana ad “alto contenuto tecnico”.
Ghiacciaio del Ventina, sabato 9 giugno 2007
Ed ecco arrivare l’atteso fine settimana in ghiacciaio, ospiti del
rifugio “Capanna Ventina”, per me collegamento con il piacevole ricordo
dell’esperienza vissuta con il corso ghiaccio di luglio 2006.
Non c’è più la stessa tranquillità di quella settimana perché siamo un
gruppo più numeroso e nemmeno gli unici ospiti del rifugio, ma sia
l’accoglienza che i pizzoccheri della cena sono sempre ottimi.
Nel pomeriggio, subito dopo aver sistemato la nostra roba nelle camere
assegnateci, eccoci partire verso il ghiacciaio per la progressione
individuale con piccozza e ramponi e lo studio dei passi in salita e
discesa; l’ambiente è stimolante e compensa del fatto di camminare oltre
due ore per farne neanche altrettante di esercitazione.
La serata scorre piacevolmente chiacchierando in allegria, il gruppo ha
oramai raggiunto un ottimo affiatamento e l’ambiente del rifugio ne fa
da cornice ideale. Però nessuno fa tardi perché l’indomani ci sarà… da
lavorare.
 Ghiacciaio del Ventina, domenica 10 giugno 2007
Ghiacciaio del Ventina, domenica 10 giugno 2007
Quante volte, durante un corso come in questo caso o prima di
un’ascensione, si vorrebbe non avere impegni di sorta e rimanere a letto
a lungo, alzarsi con calma, fare colazione tranquillamente e rimanere ad
oziare nei dintorni del rifugio in rilassatezza?
Ma questo non è il
nostro caso e la colazione alle sette e trenta è già un lusso e alle
otto tutti pronti per partire alla volta del ghiacciaio.
Dopo un’ora e trenta eccoci calzare i ramponi e impugnare le piccozze;
legati in cordata gli allievi progrediscono provando il passo incrociato
e il passo misto, mentre gli istruttori, al loro fianco o poco discosti,
osservano, aiutano o danno consigli e direttive.
Così si arriva in zona seracchi e lì viene preparato “il campo” per le
prove di trattenuta, mentre arriva una nuvola antipatica che coprendo il
sole fa abbassare notevolmente la temperatura proprio nel momento meno
opportuno.
Durante le simulazioni se ne vedono un po’ di tutti i colori, sia in
base alla capacità di eseguire la manovra correttamente, sia per il
variare del rapporto di peso tra chi scivola e chi trattiene, comunque,
se non altro, tutti hanno capito in che consiste la manovra e pure di
quanto sia aleatoria, a volte ed in certe condizioni, la sicurezza sul
ghiacciaio.
Poi si rientra al rifugio, si preparano le proprie cose e si scende a
valle.
Immancabile l’appuntamento attorno al tavolo “transformer”, ancora
salami, patatine, torte dolci e salate, vini in abbondanza, tanto
nessuno dovrà guidare, ci sarà l’autista a farlo e a lui nessuno offre
da bere, ma non è certo per scortesia.
Pian dei Fiacconi, sabato 23 giugno 2007
Il tempo è ancora al bello così come è stato per quasi tutto il corso se
si esclude “l’invernale” in Appennino del 25 marzo e di certo è quello
che ci vuole per puntare alla cima della regina delle Dolomiti: la
Marmolada.
La giornata prevede il trasferimento in pullman a Pian Fedaia per poi
salire al Rifugio di Pian Fiacconi dove si effettuerà il pernottamento
per partire presto al mattino alla volta della vetta.
Nel pomeriggio, secondo “voci” raccolte presso gli istruttori del corso,
è previsto “cazzeggio”, una parola che presenta molti significati
positivi.
Alla bidonvia si caricano gli zaini da spedire su al rifugio e, siccome
serve anche qualcuno che li “accompagni” per sistemarli all’arrivo, mi
offro spontaneamente e “disinteressatamente” di salire a mia volta,
visto che tutti gli altri, eccetto Maura e Mirta, gradiscono farsi la
passeggiata a piedi.
Una volta sistemati tutti gli zaini mi concedo anche un piatto di speck
e “un’ombra de vìn rosso”, spegnendo sul nascere i sensi di colpa che si
dibattono al mio interno.
Ottima la cena al rifugio e serata che dà veramente il senso della
montagna, pur con qualche disagio (leggi scarsità di bagni in ragione
dell’affluenza) tipico di tutti i rifugi di montagna e delle comodità
cui ci siamo fin troppo abituati.
Marmolada, domenica 24 giugno 2007
 La sveglia è alle cinque: giusto in tempo per alzarsi ad ammirare i
colori dell’alba di una giornata che si annuncia tutta da godere.
Colazione alle cinque e trenta e partenza dal rifugio alle sei e un
quarto precise: la fila si dipana ordinata su per le rocce arrotondate e
levigate avviandosi verso il ghiacciaio e, alla prima neve, ci si
mettono i ramponi, ci si lega in cordata e si parte.
La sveglia è alle cinque: giusto in tempo per alzarsi ad ammirare i
colori dell’alba di una giornata che si annuncia tutta da godere.
Colazione alle cinque e trenta e partenza dal rifugio alle sei e un
quarto precise: la fila si dipana ordinata su per le rocce arrotondate e
levigate avviandosi verso il ghiacciaio e, alla prima neve, ci si
mettono i ramponi, ci si lega in cordata e si parte.
La Marmolada è veramente una bella montagna e la sua normale regala
belle sensazioni e panorami di ampio respiro sulle cime e valli
circostanti, senza frapporre troppe difficoltà, soprattutto attualmente
che il tratto di roccette che collega la conca del ghiacciaio alla
spalla superiore che conduce sulla vetta è stato attrezzato con funi
metalliche.
Ogni cordata va in relativa autonomia con l’unica iniziale
raccomandazione di tenere contatto visivo per evitare che una cordata
possa rimanere isolata, anche se il problema dei crepacci è assai
limitato, anche per il fatto che quei pochi presenti sono facilmente
individuabili con una giornata così limpida e soleggiata.
Un primo gruppo di cordate marcia veloce, un secondo procede più
lentamente e in questo c’è anche la mia cordata che tocca la vetta alle
dieci esatte, dopo avere incrociato il primo gruppo sulla spalla nevosa,
già avviato in discesa.
Quando a nostra volta scendiamo ci troviamo sul cavo metallico lungo le
roccette a fare i conti con i tanti che salgono cercando, gli uni e gli
altri, di non creare intralci reciproci e soprattutto di non far cadere
sassi.
 Così si riapproda sul ghiacciaio e si ritorna a fare cordata seguendo
tutte le regole dettate dalla sicurezza, la qual cosa contrasta in
maniera stridente quando, inaspettatamente, ci troviamo ad incontrare un
gruppetto di ragazzi vestiti da città, con scarpe normali, senza
imbragatura e con i giubbotti sotto al braccio.
Così si riapproda sul ghiacciaio e si ritorna a fare cordata seguendo
tutte le regole dettate dalla sicurezza, la qual cosa contrasta in
maniera stridente quando, inaspettatamente, ci troviamo ad incontrare un
gruppetto di ragazzi vestiti da città, con scarpe normali, senza
imbragatura e con i giubbotti sotto al braccio.
In due ore e mezza siamo di nuovo al rifugio e ci apprestiamo a scendere
al pullman che attende a Pian Fedaia dal cui bagagliaio viene estratto
il tavolo “transformer” che ben presto si riempie di ogni ben diddio,
mentre una brezzolina pungente invita ad indossare una felpa e stimola
l’appetito.
Sarà questo l’ultimo “spuntino” di un corso di alpinismo che si è
rivelato ricco di esperienze sia tecniche che umane e di soddisfazioni
per tutti, sia allievi che istruttori.
Gabriele Villa
Diario del 27° corso di alpinismo del CAI Piacenza
Marzo - Giugno 2007
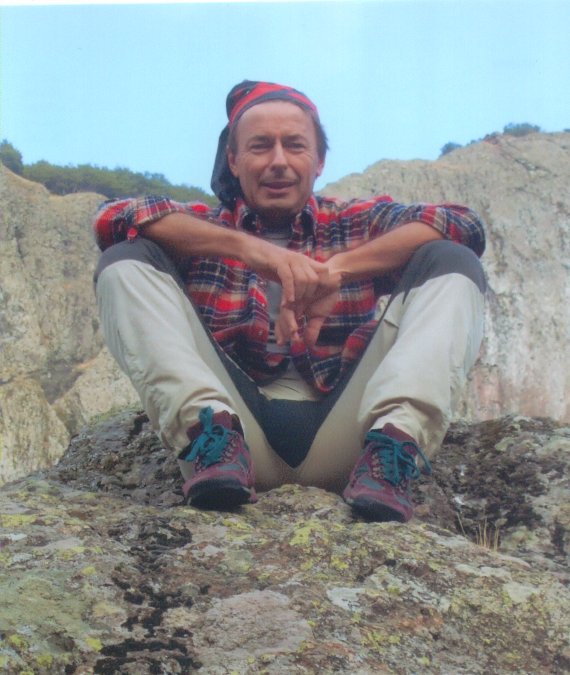 Ricordo, oramai qualche anno fa, nel pieno di un’infervorata discussione
sull’arrampicata, sulla didattica e gli scopi dei corsi di roccia e
alpinismo, sulle dinamiche interpersonali all’interno della vita
associativa del Cai, sentirmi rivolgere una domanda netta, a bruciapelo,
con decisione quasi provocatoria: “Ma tu, non ti sei ancora stancato
di fare il Don Chisciotte?”
Ricordo, oramai qualche anno fa, nel pieno di un’infervorata discussione
sull’arrampicata, sulla didattica e gli scopi dei corsi di roccia e
alpinismo, sulle dinamiche interpersonali all’interno della vita
associativa del Cai, sentirmi rivolgere una domanda netta, a bruciapelo,
con decisione quasi provocatoria: “Ma tu, non ti sei ancora stancato
di fare il Don Chisciotte?”  Il trasferimento da Piacenza verso la Val d’Aosta avviene con il pullman,
destinazione Gressoney.
Il trasferimento da Piacenza verso la Val d’Aosta avviene con il pullman,
destinazione Gressoney. 

 Un inconsueto appuntamento mi attende, alle ore otto, all’uscita
autostradale di Brescia Est.
Un inconsueto appuntamento mi attende, alle ore otto, all’uscita
autostradale di Brescia Est.

 Ed ecco arrivare il primo dei tre fine settimana che completeranno il
corso.
Il teatro delle esercitazioni del sabato è il Dente delle Ali quello
che, nella guida “AEMILIA” che descrive le “arrampicate su roccia e
ghiaccio in provincia di Piacenza”, viene presentato come “la palestra
storica della nostra provincia, la madre di tutte le nostre falesie”.
Ed ecco arrivare il primo dei tre fine settimana che completeranno il
corso.
Il teatro delle esercitazioni del sabato è il Dente delle Ali quello
che, nella guida “AEMILIA” che descrive le “arrampicate su roccia e
ghiaccio in provincia di Piacenza”, viene presentato come “la palestra
storica della nostra provincia, la madre di tutte le nostre falesie”. L’intero gruppo raggiunge un sassone alto una decina di metri nei pressi
della parete della Rocca del Prete, presso cui saranno effettuate tutte
le prove tecniche sui materiali e le “trattenute” di un volo in parete
ed ancora più evidente appare l’organizzazione meticolosa impressa dal
direttore del corso, Lucio Calderone, ben coadiuvato dai solerti
istruttori.
L’intero gruppo raggiunge un sassone alto una decina di metri nei pressi
della parete della Rocca del Prete, presso cui saranno effettuate tutte
le prove tecniche sui materiali e le “trattenute” di un volo in parete
ed ancora più evidente appare l’organizzazione meticolosa impressa dal
direttore del corso, Lucio Calderone, ben coadiuvato dai solerti
istruttori.  Soddisfatti ci si trasferisce sulla parete della Rocca del Prete dove un
tratto ferrato (da fare con dissipatore) conduce su di un pulpito da cui
tutti scenderanno con due corde doppie da fare in sequenza.
Soddisfatti ci si trasferisce sulla parete della Rocca del Prete dove un
tratto ferrato (da fare con dissipatore) conduce su di un pulpito da cui
tutti scenderanno con due corde doppie da fare in sequenza.  Ghiacciaio del Ventina, domenica 10 giugno 2007
Ghiacciaio del Ventina, domenica 10 giugno 2007 La sveglia è alle cinque: giusto in tempo per alzarsi ad ammirare i
colori dell’alba di una giornata che si annuncia tutta da godere.
Colazione alle cinque e trenta e partenza dal rifugio alle sei e un
quarto precise: la fila si dipana ordinata su per le rocce arrotondate e
levigate avviandosi verso il ghiacciaio e, alla prima neve, ci si
mettono i ramponi, ci si lega in cordata e si parte.
La sveglia è alle cinque: giusto in tempo per alzarsi ad ammirare i
colori dell’alba di una giornata che si annuncia tutta da godere.
Colazione alle cinque e trenta e partenza dal rifugio alle sei e un
quarto precise: la fila si dipana ordinata su per le rocce arrotondate e
levigate avviandosi verso il ghiacciaio e, alla prima neve, ci si
mettono i ramponi, ci si lega in cordata e si parte. Così si riapproda sul ghiacciaio e si ritorna a fare cordata seguendo
tutte le regole dettate dalla sicurezza, la qual cosa contrasta in
maniera stridente quando, inaspettatamente, ci troviamo ad incontrare un
gruppetto di ragazzi vestiti da città, con scarpe normali, senza
imbragatura e con i giubbotti sotto al braccio.
Così si riapproda sul ghiacciaio e si ritorna a fare cordata seguendo
tutte le regole dettate dalla sicurezza, la qual cosa contrasta in
maniera stridente quando, inaspettatamente, ci troviamo ad incontrare un
gruppetto di ragazzi vestiti da città, con scarpe normali, senza
imbragatura e con i giubbotti sotto al braccio.