Un sogno a forma di diedro
Scalata del gran
diedro Livanos-Gabriel alla Cima Su Alto, in Civetta
di Gabriele Villa
I sogni non hanno scadenza, nemmeno quando vengono realizzati, anzi, le
emozioni provate nel concretizzarli si rafforzano nel tempo, ne esaltano
in noi le sensazioni sperimentate, aggiungendo a volte un pizzico di
nostalgia al ricordo, tal altre rivestendo di una patina di epicità ciò
che si è vissuto, aggiungendo sostanza alle emozioni che hanno inciso la
corteccia cerebrale in maniera indelebile.
Gli alpinisti, forse più di altri, hanno la fortuna di coltivare sogni
(che si chiamano “vie da ripetere”), di poterli realizzare e subito
rinnovarli inventando altri sogni che possono essere fatti di tante
sfumature: l’importanza storica di una via, la sua esteticità, la fama
dei primi salitori e di famosi ripetitori, il fascino di una cima, la
sua eleganza, le stesse difficoltà tecniche e/o di ambiente.
Ho avuto la fortuna di provarlo di persona, ho sperimentato e assaporato
tutti gli ingredienti di questa miscela esaltante (una specie di T.N.T.
psicologico), ne conservo dentro di me memoria indelebile e pure l’ho
riconosciuta negli occhi e nelle parole di amici che hanno vissuto e
realizzato sogni ancora più grandi dei miei.
Questo è il racconto di uno di quei sogni di cui ho gioito assieme a
loro, all’inizio quando me lo comunicarono al telefono mentre erano
ancora sul sentiero di rientro dopo la scalata, successivamente, dopo
oltre un anno, in un colloquio di cui avevo conservato la voglia e che è
arrivato senza fretta, con naturalezza e spontaneità, rinnovando il
piacere dell’esperienza vissuta nel ricordo di chi la raccontava e
di chi la ascoltava e ne scriveva.
 Per
cominciare, ecco le impressioni e considerazioni personali da me scritte “a
caldo” in un post pubblicato su intraisassblog in data sabato 20
settembre 2008.
Per
cominciare, ecco le impressioni e considerazioni personali da me scritte “a
caldo” in un post pubblicato su intraisassblog in data sabato 20
settembre 2008.
IL DIEDRO DEI DIEDRI
La telefonata mi aveva raggiunto mentre, seduto al computer, stavo
scrivendo assorto:
“Sono Chicco, sono con Paolo e stiamo scendendo per la Val Corpassa. Ti
dico solo un nome Georges … ti dice niente?”.
Non riesco a fare subito mente locale e sento la voce che continua:
“Su Alto …”.
Mi sfugge un “Nooooo… avete fatto il diedro Livanos alla Su Alto? …
siete proprio forti”.
Scrive Alessandro Gogna in “Dolomiti e calcari del Nordest” della CDA &
Vivalda Editori.
[Nei tre giorni di salita, 10, 11, 12 settembre 1951, Livanos e Gabriel
piantarono 99 chiodi (più 26 di sosta). Siccome lo zoccolo non ne
richiede l’uso, il numero deve essere ripartito su quattrocento metri:
la media è quindi di circa un chiodo ogni tre metri, stesso livello
quindi della Comici-Dimai alla Grande. Le due medie simili non
ingannino: tra le due salite esiste un forte dislivello di difficoltà di
chiodatura, colmabile soltanto dalla maggiore esperienza di diciotto
anni di differenza storica.
Anche il materiale era diverso: già nel 1945 erano apparse le prime
corde di nylon… Pierre Allain nel frattempo aveva costruito i primi
moschettoni superleggeri (e questo nell’arrampicata artificiale volle
dire molto); erano apparsi i primi cunei di legno (anche se Livanos nel
gran diedro ne piantò uno solo con la scusa che dove entra un cuneo
entra anche una mano…) e le prime staffe a gradini di metallo o di
legno; i chiodi erano prodotti da alcune ditte. … Ciò che preme
sottolineare in ultimo è il perfetto equilibrio che con questa salita si
creò tra libera e artificiale. Dopo di essa vennero le esagerazioni.
Come ben dice Motti, in quel tempo “il lavoro di chiodatura arriva a dei
livelli veramente artistici, richiedendo grandissimo intuito nello
scoprire i buchi nascosti e le fessure superficiali. Molti arrampicatori
di questo periodo hanno veramente creato dei capolavori lungo le
strapiombanti pareti dolomitiche; con i soli mezzi normali, senza mai
forare la roccia, sono riusciti a passare dove moltissimi altri
probabilmente avrebbero dovuto “bucare”. In questo senso l’arrampicata
artificiale ha tutta una sua dimensione altamente creativa…]
E Gino Buscaini in “Le Dolomiti Orientali” – Zanichelli – 1984
[Oggi c’è una tendenza a sottostimare le vie con tratti in arrampicata
artificiale. Direi che il diedro Livanos si presta a rivedere qualche
giudizio un po’ superficiale di questo tipo; anzitutto perché la
risoluzione dell’itinerario risulta logica e con bella dirittura, in
secondo luogo perché l’impegno tecnico è molto elevato anche con
l’impiego di chiodi e di cunei (intendiamoci: di chiodi normali e di
cunei di legno – la via è del 1951)]
 Se
c’era qualcosa del Civetta che si vedeva bene da Pecol di San Tomaso era
la “Triade”. Credo sia stato lo zio Mario a insegnarmi i nomi di quelle
cime: a sinistra la De Gasperi, in mezzo la Su Alto, a destra la
Terranova.
Se
c’era qualcosa del Civetta che si vedeva bene da Pecol di San Tomaso era
la “Triade”. Credo sia stato lo zio Mario a insegnarmi i nomi di quelle
cime: a sinistra la De Gasperi, in mezzo la Su Alto, a destra la
Terranova.
Quando ero più piccolo credevo fossero quelle le cime più alte del
Civetta, poi crebbi un po’ e imparai cos’era la prospettiva, ma ciò non
cambiò la mia considerazione per la Triade perché dalla visuale di
Pecol, sembrava incombere, presenza “estetica” e dominante, sfondo alto
e lontano delle mie estati adolescenziali.
Delle tre mi piaceva maggiormente la Su Alto, ma solamente per via del
nome che mi aveva suggestionato, ancora ragazzino. Successivamente mi
piacque anche esteticamente ed era proprio per quel suo cangiare di
colore che ad ogni tramonto si rinnovava, soprattutto nelle sere di
enrosadira.
Cosa fosse un “diedro” mica lo sapevo, ma avevo ben imparato che il
cambiare di colori che sembrava dividere la cima Su Alto in due parti,
dallo zoccolo fino alla vetta con una grande ininterrotta “sfessa”, era
causato da quelle due pareti che si incontravano ad angolo e a sera
riverberavano diversamente la luce solare verso il tramonto.
Sono passati gli anni e con la passione per l’alpinismo e la lettura dei
tanti libri che lo raccontano, imparai molto più di quelle cime, delle
vie difficili ed impressionanti che vi erano state tracciate sopra.
Sono contento che i miei amici Michele Scuccimarra (Chicco) e Paolo
Gorini (il Doc) abbiano ripetuto tra le tante vie storiche, difficili ed
“importanti”, proprio quella del diedro Livanos. Sono contento che a
Ferrara ci siano alpinisti in grado di ripercorrere le vie dei “grandi”
e, questa volta, ancora più di altre, mi sono sentito vicino a loro.
E la cosa che ho invidiato loro è stato proprio il tramonto goduto nella
grotta del bivacco, guardando verso ponente, verso la montagna di San
Tomaso, un specie di panorama “all’incontrario” di quello goduto da me
nelle felici estati giovanili.
Credo che il post faccia ben comprendere quanto la notizia della scalata
mi avesse colpito toccandomi fino nell’intimo, vuoi per la familiarità
dei luoghi che per la conoscenza della montagna che ne era stata
protagonista.
E siccome di “impresa” alpinistica si trattava eccomi rinverdire i miei
trascorsi giornalistici e prendere carta e penna (si fa per dire… perché
da quando ci sono i computer si deve parlare di video e tastiera) e
scrivere un comunicato per i quotidiani cittadini e così la notizia
dell’ascensione aveva trovato un meritato riscontro anche sulla stampa
locale:
 Ripetuta
da una cordata ferrarese la scalata del Gran Diedro Livanos alla cima Su
Alto nel gruppo del Monte Civetta.
Ripetuta
da una cordata ferrarese la scalata del Gran Diedro Livanos alla cima Su
Alto nel gruppo del Monte Civetta.
Nei giorni scorsi una cordata
ferrarese ha compiuto una notevole impresa alpinistica sulla parete
nord-ovest del Monte Civetta, in Valle agordina, ripetendo la difficile
e rinomata via del Gran Diedro della cima Su Alto.
Si tratta di Michele Scuccimarra e Paolo Gorini che nei giorni 29/30/31
agosto hanno ripetuto la via dei francesi Georges Livanos – Robert
Gabriel, aperta in tre giorni di scalata nel lontano settembre del 1951
e considerata a tutt’oggi una delle “classiche” più difficili del
gruppo.
Si tratta di un percorso lungo circa 800 metri, composto nella prima
metà da uno “zoccolo” di terzo e quarto grado e nella seconda parte da
un diedro regolare di roccia gialla e friabile in cui si concentrano le
difficoltà che arrivano fino al sesto grado in arrampicata libera e al
grado A2 in arrampicata artificiale.
I due ferraresi partiti da Ferrara ancora prima dell’alba il 29 agosto
si sono portati in Val Civetta e qui hanno risalito i primi quattrocento
metri dello zoccolo per andare a bivaccare in una grotta naturale
situata proprio all’inizio del gran diedro, già bivacco dei primi
salitori.
Trascorsa una notte abbastanza confortevole hanno ripreso a salire il 30
agosto arrampicando fino a sera ed issando con la corda il saccone
contente tutto il materiale da bivacco, in modo da poter arrampicare più
leggeri.
Una volta arrivati in vetta hanno subito iniziato la discesa
raggiungendo, alla luce delle pile frontali, il bivacco fisso Cesare
Tomè al Giazzèr (una struttura a semibotte con quattro cuccette) dove
hanno trascorso la notte del 30 agosto per riprendere la discesa verso
valle al mattino dopo e tornare all’auto e fare rientro a Ferrara.
Pur molto diversi nelle rispettive professioni, Michele Scuccimarra (che
è orafo artigiano) e Paolo Gorini (che è medico chirurgo), condividono
la grande passione per le scalate.
La loro cordata è certamente la più affiatata in ambito ferrarese e non
è nuova a queste imprese avendo già salito sempre sulla parete nord –
ovest del Civetta, vie come la storica Solleder – Lettembauer, (1250
metri con difficoltà fino al sesto grado inferiore) e la difficile Aste
– Susatti (800 metri con difficoltà fino al sesto grado superiore).
Decantati i ricordi e le sensazioni, archiviata la scalata come
prestazione alpinistica, rimaneva la voglia di quella chiacchierata per
poter entrare nei dettagli “intimi”, cioè nelle sensazioni, emozioni,
visioni, fatiche, timori, speranze, gioie vissute dai due protagonisti.
E da dove avrebbe potuto venire, finalmente, lo spunto per quella tante
volte auspicata chiacchierata se non da un fortuito incontro sulle mura
cittadine con Paolo il “Doc”, durante i rispettivi momenti di
allenamento?
“Quando ci vediamo per quella chiacchierata sul diedro Livanos?”
“Guardo i miei turni e ti telefono la serata libera, poi tu ti accordi
con Chicco”
Già, perchè era lui il perno della questione con i suoi turni in
ospedale e le serate di reperibilità, ma quella sera il telefono aveva
squillato dopo cena e … ecco fissato l’appuntamento: venerdì 9 ottobre
2009, alla palestra di arrampicata del Monodito.
Il venerdì sera la palestra è sempre poco frequentata, ma quella sera
“fa gioco” perché garantirà tranquillità, anche se la mia “intervista”
sarà comunque sui generis perché io ho il mio quadernone degli appunti e
la penna (e scriverò), loro… imbragatura, scarpette e secchiello per la
sicura (e arrampicheranno).
Me l’ero immaginata un po’ diversa questa chiacchierata ma, conoscendo i
personaggi, non mi meraviglio più di tanto, per cui prendo una seggiola,
mi sistemo vicino alla parete di arrampicata prescelta e comincio con la
prima domanda.
 Come vi è venuta l’idea della salita?
Come vi è venuta l’idea della salita?
Chicco: perché è bella e ci sono retaggi storici.
Paolo: era un’idea che mi girava da tempo nella testa.
Chicco: leggi sui libri le storie dei salitori, senti l’enfasi, al
contempo si crea anche curiosità.
Ma, nel concreto, come vi siete accordati nella scelta?
Chicco: è successo che ho telefonato a Paolo e gli ho detto:
“Senti, avrei pensato al diedro Livanos alla Su Alto”.
Paolo: gli ho risposto “Ho appena chiuso il libro sulla relazione della
via”.
Chicco: puoi ben immaginare che a quel punto il 50% era già fatto: non
potevano esserci altri obiettivi se non quello.
Paolo: così è successo, più o meno, anche per la via Solleder -
Lettembauer al Civetta.
Scrivo con la testa china sul mio quadernone mentre sento le due voci
che si rincorrono, senza mai sovrapporsi, in un discorso a “tiri
alterni”, come in cordata affiatata, per dirmi che dalla telefonata
intercorsa ai preparativi per la salita erano trascorse al massimo
settantadue
ore.
La sera stessa della telefonata (il mercoledì) si erano trovati in
palestra per cominciare a parlare della logistica e cominciare ad
abbozzarla, decidendo già la partenza per il venerdì mattina con
l’obiettivo di arrivare a bivaccare nella grotta alla base del diedro.
Pur se la decisione era stata fulminea, mi pare però che le idee le
avevate chiare.
Chicco: volevamo vivere la scalata alla Armando Aste, per intenderci,
cioè stare sulla montagna, goderla senza fretta, e quindi abbiamo scelto
di conseguenza la strategia.
Paolo: per me era il primo bivacco progettato a tavolino, cioè voluto e
organizzato.
Chicco: abbiamo fatto tutto in stile big wall, con il saccone da
recupero al seguito.
Per arrivare alla grotta ci sono tre tiri impegnativi dopo lo zoccolo,
con un traverso marcio di V+.
Con 20 chilogrammi sulla schiena puoi ben immaginare che “festa” sia
stata per me.
Mentre parliamo i mie due amici infilano le imbragature, si legano e
iniziano ad arrampicare.
 Beh? … e l’intervista?
Beh? … e l’intervista?
Chicco: ma guarda che ti sentiamo, eh? Nel frattempo ci alleniamo.
Intanto Paolo continua a parlare con occhi trasognati, come se fosse
ritornato in parete.
Paolo: il bivacco in parete fa la differenza: sei lì con la testa e solo
lì. Non è che il giorno dopo ti svegli e non ti va di arrampicare …
Quando Livanos arrivò lì in fase di apertura della via trovò la grotta
col fondo già spianato e con il muretto a secco già preparato.
Lo sapevano tutti gli alpinisti di quella grotta, ed era come l’abbiamo
trovata noi.
A che ora siete arrivati alla grotta?
Chicco: siamo arrivati alle cinque e mezza del pomeriggio perché siamo
saliti con comodo. Sapevamo fin dall’inizio che saremmo arrivati lì e
solo lì.
Paolo: dal saccone è uscita anche la polenta coi funghi, ma a parte
quello l’emozione grande è stato leggere i nomi dei “grandi” scolpiti
sulle pareti della grotta a martellate.
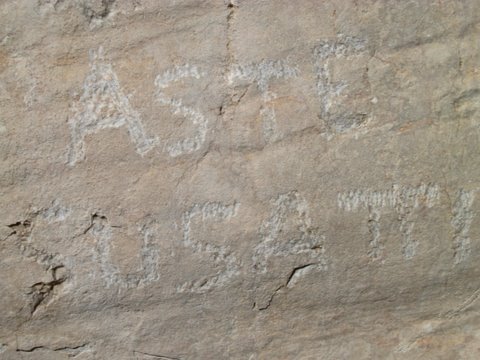 Chicco: è la cosa che più ti rimane questa emozione. La via la perdi, le
emozioni rimangono.
Chicco: è la cosa che più ti rimane questa emozione. La via la perdi, le
emozioni rimangono.
Paolo: … e tutto il variare dei colori mentre si è spenta la giornata e
alla fine sono rimasti solo i profili scuri delle montagne intorno.
Chicco: e il rifugio Tissi ad un certo punto era al buio e noi ancora
illuminati dal sole. Arrivare alla grotta con ancora quattro ore di luce
ti permette di goderti il bivacco, tanto che l’idea di attrezzare due o
tre tiri di corda l’abbiamo accantonata subito.
Paolo: poi ci sono state le telefonate a casa e agli amici. Uno di loro
(Paolo Montanari NdR) non aveva capito subito che eravamo in parete e
dentro la grotta e quando realizzò la cosa ne fu entusiasta.
Si senti la voce uscire dal cellulare, quasi a gridare: “Mitici!”.
Chicco: devo dire che per me il bivacco è stato un’emozione superiore a
ogni aspettativa.
Oramai sono in piena parete i miei due amici, cavalcando l’onda del
ricordo e allo stesso tempo sono in parete pure realmente, su quella
artificiale di legno con le prese avvitate e si alternano a “tirare”
sulle linee che guardano gli specchi, di fronte a me che, seduto,
continuo a scrivere.
 E con il dormire come l’avete messa?
– chiedo immaginando le emozioni di
quella notte.
E con il dormire come l’avete messa?
– chiedo immaginando le emozioni di
quella notte.
Chicco: devo dire che io credo di essere odiato dai miei compagni di
bivacco perché dopo due secondi che mi sono coricato, mi addormento e
russo.
Paolo: io ho pensato a ciò che mi attendeva il giorno dopo, lui ha
rispettato le sue abitudini.
Ho pensato a ciò che avevo sopra la testa, quattrocento metri di diedro
di estrema difficoltà.
E la colazione al mattino successivo?
Chicco: abbondante e ottima.
Paolo: ricordo che alle sette e trenta ho detto, “sarà mica il caso di
muoversi?”
Abbiamo preparato il the caldo, marmellate, biscotti, ma … tranquilli,
senza fretta.
Chicco: a Nord Ovest non si può partire troppo presto, fa freddino, non
conviene.
Sicché alle otto e quaranta tutto è pronto per la scalata e i due amici
attaccano il diedro e arrampicano per tutto il giorno senza
interruzione, ad ogni sosta recuperando il saccone con tutto il loro
materiale da bivacco al seguito e alle venti e quaranta (cioè
esattamente dodici ore dopo) sono sulla cima della Su Alto.
Dodici ore di scalata che Chicco riassume abbastanza sinteticamente.
Chicco: siamo andati abbastanza veloci fino al tetto, poi siamo andati
verso destra dove abbiamo visto il bivacco dei primi salitori, da lì si
va a sinistra fino ad imboccare i camini finali. Si tratta di strettoie
e imbuti e poi c’è ancora un traverso in alto.

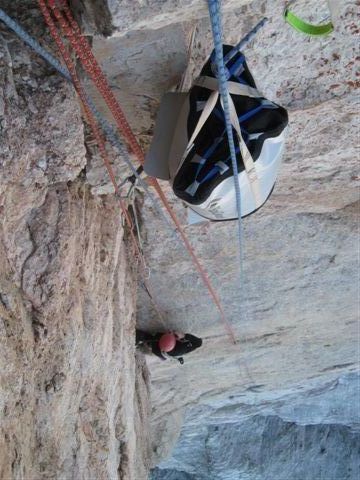
Quindi la bellezza della via non è nella buona qualità della roccia?
Paolo: l’arrampicata nel diedro è molto bella, oltre che sostenuta. Meno
piacevole è la parte alta. Va detto che per avere la fama di via in
artificiale c’è tanta, ma tanta arrampicata libera.
Oramai è calato il tramonto e i due amici iniziano la discesa versò il
Giazzèr dove sanno di poter trovare riparo nel Bivacco fisso Cesare Tomè.
 Paolo: mi ero documentato bene e siamo scesi nella direzione giusta,
trovando anche qualche ometto di segnalazione. Il problema è stato la
nebbia.
Devo dire che è stata utile una foto del libro di Visentini che
ricordavo di avere visto sul libro delle vie normali al Civetta. Una
foto scattata proprio al Bivacco Tomè che mi è stata molto utile per
trovare l’orientamento. Poi Chicco è arrivato al bivacco.
Paolo: mi ero documentato bene e siamo scesi nella direzione giusta,
trovando anche qualche ometto di segnalazione. Il problema è stato la
nebbia.
Devo dire che è stata utile una foto del libro di Visentini che
ricordavo di avere visto sul libro delle vie normali al Civetta. Una
foto scattata proprio al Bivacco Tomè che mi è stata molto utile per
trovare l’orientamento. Poi Chicco è arrivato al bivacco.
Chicco: per merito tuo che mi hai orientato.
Sono oramai le ventitre quando i due arrivano a mettere piede nel
bivacco.
Chicco: abbiamo trovato un minestrone scaduto nel 2005, lo ricordo
esattamente.
Per prudenza lo abbiamo fatto bollire un po’ di più di quanto era
prescritto e … com’era buono!
Anche se i piselli sembravano sassi di malachite.
Della nostra roba ci era rimasto del formaggio e l’occorrente per la
colazione del mattino dopo.
C’era euforia nell’aria, dentro al bivacco, e siamo rimasti a lungo a
parlare, a confrontarci.
Paolo: il bello è che le cose sono andate come le avevi pensate e anche
quella era una soddisfazione.
Fondamentale però è stato il momento della telefonata tra di noi
precedente al via e la contemporaneità con la quale entrambi ci avevamo
pensato.
Il più era indubbiamente fatto, ma la discesa che vi rimaneva da fare
l’indomani era ancora lunga, anche se non certo da perderci il sonno di
un’altra notte.
Chicco: dal Tomè c’è ancora da brigare un po’ e bisogna farla con una
buona visibilità, se no puoi rischiare di farti del male.
Paolo: ero al corrente che Livanos aveva tribolato in discesa, facendo
svariate corde doppie senza sapere dove sarebbe arrivato.
Chicco: il bivacco Tomè è una perla incastonata tra le rocce. Poi c’è il
libro delle arrampicate che è un collegamento tra tutti gli alpinisti
che sono passati di lì. Mentre vai via ti giri in continuazione a
fotografarlo e quando arrivi a casa e guardi le foto ti chiedi “ma
quante gliene ho fatte?”.


Intanto la serata sta volando via e i miei amici, esaurite le salite del
“versante est” passano ad arrampicare sul lato del tetto, mentre io mi
sdraio sui materassi sotto al boulder reclinabile.
Loro faticano e io rileggo gli appunti che ho scritto.
Sono pochissime le note tecniche circa l’arrampicata, si è parlato poco
di gradi di difficoltà, ma tanto di sensazioni, di visioni, di emozioni.
Ho visto la luce dei loro occhi mentre le raccontavano con entusiasmo
ben quattordici mesi dopo la salita, un entusiasmo che ho condiviso
immedesimandomi nella loro avventura e rivivendola assieme a loro.
La chiacchierata si conclude con un’ultima riflessione di Chicco:
"Credo ci sia una cosa che la dice lunga. Sommando le vie che io e Paolo
abbiamo salito singolarmente nel gruppo del Civetta ne cumuliamo
qualcosa come quarantacinque e questo mi pare spieghi bene perché ci
intendiamo così bene. Il fatto è che la Civetta o la ami o la temi."
Si sente una punta d’orgoglio nella voce del mio amico, ma mi pare più
che giustificato.
Concludo anch’io con una riflessione che ho fatto tra me e me:
“Loro la Civetta la amano e la scalano, io invece l’amo anche senza
scalarla perché è la montagna al cospetto della quale ho trascorso le
mie felici estati di fanciullo e di ragazzo a Pecol di San Tomaso
Agordino”.

Quindi non posso che ripetere quanto ho scritto nel post di intraisass:
[E la cosa che ho invidiato loro è stato proprio il tramonto goduto
nella grotta del bivacco, guardando verso ponente, verso la montagna di
San Tomaso, un specie di panorama “all’incontrario” di quello goduto da
me nelle felici estati giovanili.]
Cioè la parete nord ovest della Civetta, e la “triade” (con le cime De
Gasperi - Su Alto – Terranova) e al centro la Su Alto segnata nel mezzo
da quel diedro che nelle sere di enrosadira sembrava incendiarsi per
metà.
Gabriele Villa
Un sogno a forma di diedro
Ferrara, mercoledì 13 gennaio 2010

 Ripetuta
da una cordata ferrarese la scalata del Gran Diedro Livanos alla cima Su
Alto nel gruppo del Monte Civetta.
Ripetuta
da una cordata ferrarese la scalata del Gran Diedro Livanos alla cima Su
Alto nel gruppo del Monte Civetta. 